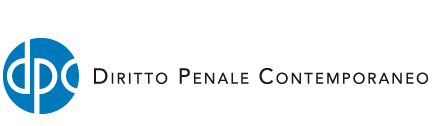Applicando tale principio di diritto al caso di specie, essi hanno
escluso la violazione dell’art. 6 § 1 Cedu in ragione del fatto che la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato belgi avevano
fornito adeguata motivazione del mancato rinvio, omologandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, come noto esclude l’obbligatorietà del rinvio pregiudiziale anche per gli organi di ultima istanza nel caso in cui:
a) un’identica questione sia
già stata affrontata dalla Corte; oppure
b) le norme abbiano un
senso chiaro e univoco. Più nel dettaglio, le supreme magistrature belghe avevano fatto riferimento alla cd. teoria dell’atto chiaro, delineata dalla Corte di Giustizia nella sentenza
Cilfit, C-283/81.
La pronuncia in esame riveste notevole importanza, tanto dal punto di vista teorico (perché è espressiva dell’odierno grado di interazione tra diritto del Consiglio d’Europa, diritto nazionale e diritto dell’UE, e consente pertanto di illuminare le più recenti dinamiche dei rapporti tra fonti e tra corti europee) quanto dal punto di vista pratico (perché, d’ora in poi, i cittadini dell’UE potranno adire la Corte di Strasburgo perché essa si pronunci sul mancato adempimento, da parte delle autorità giurisdizionali di ultima istanza, dell’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, e dunque indirettamente provveda a sanzionare l'inosservanza di tale obbligo da parte delle medesime autorità).
Quanto meno di regola, dovrebbe invero ritenersi che – prima di ricorrere a Strasburgo – i ricorrenti siano tenuti ad
esaurire le vie di ricorso interno ex art. 35 Cedu, e dunque ad azionare davanti alle competenti giurisdizioni nazionali l’azione risarcitoria esperibile a fronte della violazione, da parte dello Stato-giurisdizione, del diritto dell’UE (secondo il paradigma delineato dalla Corte di Giustizia con le sentenze
Köbler, C-224/01 e
Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, che hanno portato a compimento la parabola iniziata con la sentenza
Francovich, C-6/90 e C-9/90): la mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale rientra, infatti, tra gli elementi che il giudice interno deve valutare per verificare se vi sia stata una violazione grave e manifesta del diritto dell’UE, in presenza della quale sorge la
responsabilità patrimoniale dello Stato che, attraverso i suoi organi (in questo caso gli organi giurisdizionali), se ne è reso autore.
Resta peraltro aperto il quesito se tale regola valga anche nell'ipotesi, che qui più direttamente rileva, in cui il ricorrente si dolga della violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un processo penale da parte del giudice nazionale di ultima istanza (nel nostro caso, la Corte di cassazione), sussistendo seri motivi per dubitare che il mero rimedio risarcitorio ex post possa qui ritenersi sufficiente a riparare la lesione del diritto del ricorrente ad una corretta applicazione del diritto dell'UE: e ciò specie quando la mancata attivazione del rinvio pregiudiziale da parte della Cassazione si sia tradotta in una ingiusta condanna del ricorrente, che avrebbe dovuto invece essere assolto se fosse stata data corretta applicazione al diritto UE.